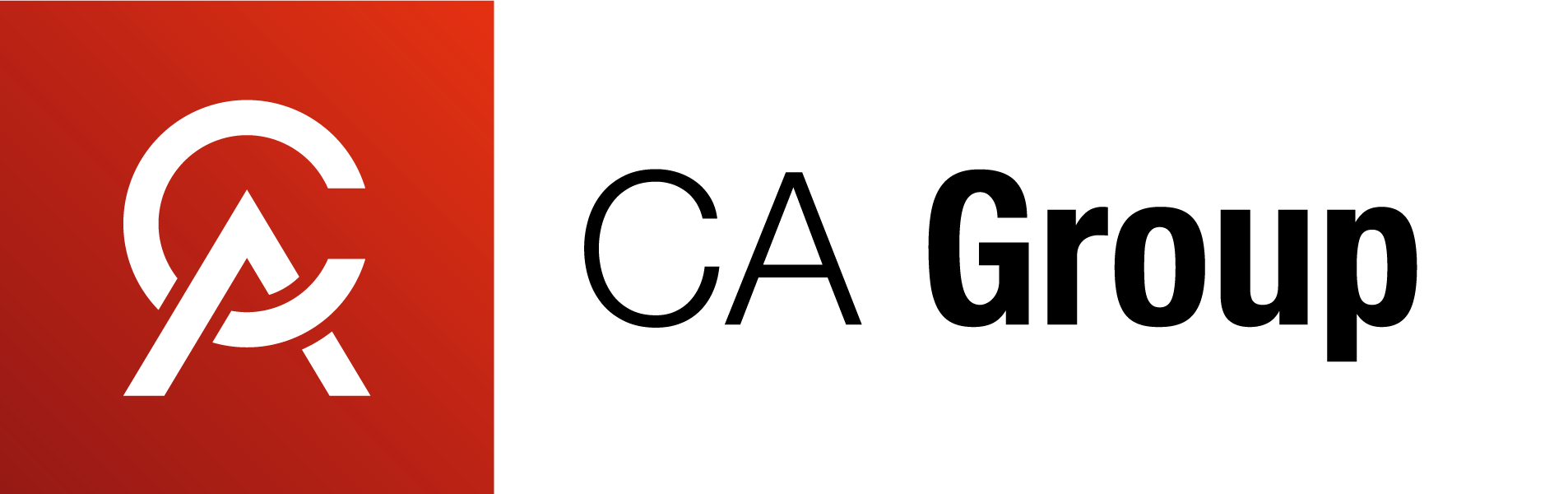Il ruolo strategico dell’ESG nelle compagnie assicurative
Negli ultimi anni i criteri ESG sono passati da scelta etica a leva strategica, incidendo direttamente su solvibilità, gestione del rischio e redditività delle compagnie assicurative. Le normative europee in evoluzione richiedono adeguamenti organizzativi e introducono parametri concreti, aprendo a nuove prospettive di governance e opportunità per chi saprà adattarsi. Questo cambiamento sta trasformando in profondità il modello di business, favorendo un approccio più integrato tra sostenibilità, gestione finanziaria e strategia aziendale.
ESG assicurazioni: scenario e impatti
Negli ultimi anni, l’integrazione dei criteri ESG è passata da ambizione etica a driver concreto per il cambiamento strutturale delle imprese, in particolare nel settore assicurativo. In un contesto normativo europeo in continua evoluzione, l’ESG non rappresenta più soltanto un’opzione reputazionale, ma un fattore che impatta direttamente sulla solvibilità, sulla gestione del rischio e sulla redditività delle Compagnie. In questo articolo, analizzeremo le principali iniziative regolamentari in ambito finanziario ed assicurativo legate alla sostenibilità, evidenziando i cambiamenti organizzativi richiesti alle Compagnie, gli impatti effettivi e potenziali sugli assetti di queste ultime e le implicazioni operative che ne derivano. Esploreremo inoltre come i fattori ESG siano sempre più legati a metriche concrete, come il rischio di default, aprendo la strada ad una visione evoluta del rischio e della governance aziendale. Una rassegna normativa, quindi, ma anche una lettura strategica delle trasformazioni in atto e delle opportunità per chi saprà adattarsi e innovare.
Il framework normativo
Il percorso verso la sostenibilità nel settore assicurativo è guidato da un articolato quadro normativo europeo, che agisce su più livelli: prudenziale, informativo, operativo e distributivo. Questo sistema regolatorio, in continua evoluzione, ha l’obiettivo di integrare i fattori ESG nelle decisioni strategiche e operative delle imprese.
Green Deal e direttive europee
Il framework normativo, guidato dal Green Deal europeo per il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050, si compone di diverse iniziative regolamentari, che riguardano i seguenti principali filoni:
- l’introduzione di nuovi obblighi di disclosure che vedono la centralità di informazioni di sostenibilità e non finanziarie;
- l’introduzione del legame tra fattori di sostenibilità e il sistema di gestione dei rischi delle Compagnie di assicurazione;
- la review dei sistemi di governance aziendale, alla luce della considerazione degli impatti ESG;
- la progettazione di prodotti sostenibili sul mercato assicurativo.
Consapevole della crescente complessità e frammentazione del quadro normativo, la Commissione Europea ha recentemente proposto un pacchetto di semplificazione, noto come Omnibus, volto a razionalizzare la disciplina esistente, ridurre gli oneri informativi per le imprese e migliorare la coerenza tra i diversi livelli regolatori. L’iniziativa, attualmente in fase di approvazione, rappresenta un primo passo verso un quadro regolatorio più equilibrato, che ne facilita l’attuazione concreta senza compromettere gli obiettivi ambientali e sociali.
L’evoluzione dell’informativa di sostenibilità e gli obblighi di disclosure
Negli ultimi anni l’informativa di sostenibilità è passata dall’essere una pratica volontaria e di immagine a un obbligo regolamentare sempre più stringente, con impatti rilevanti sul settore assicurativo. Una volta le Compagnie pubblicavano bilanci di sostenibilità principalmente a fini reputazionali; oggi, invece, sono chiamate per legge a fornire dati sempre più dettagliati, standardizzati e verificabili relativi ai fattori ESG, in un’ottica di massima trasparenza verso investitori, autorità di vigilanza e stakeholder. Questa evoluzione normativa ha sostanzialmente trasformato la disclosure ESG in un elemento centrale della strategia aziendale.
La direttiva CSRD
Al centro del cambiamento c’è la nuova CSRD che rappresenta un’evoluzione rispetto alla NFRD (Non-Financial Reporting Directive)[1]. Le imprese di assicurazione dovranno integrare le informazioni di sostenibilità nei bilanci annuali, adottando standard comuni definiti dagli ESRS. Uno degli aspetti più innovativi della CSRD è l’introduzione del principio della doppia materialità, che impone alle aziende di rendicontare sia l’impatto delle loro attività sull’ambiente e sulla società, sia i rischi ESG che potrebbero influenzare la loro performance finanziaria. Inoltre, la direttiva introduce l’obbligo di verifica esterna delle informazioni di sostenibilità, rendendo la rendicontazione ESG più affidabile e confrontabile tra le diverse realtà aziendali. L’implementazione della CSRD per le grandi imprese è prevista a partire dal 2024, mentre per le PMI quotate e altre categorie specifiche l’entrata in vigore è posticipata al 2026.
[1] Direttiva UE del 22 ottobre 2014 n. 95, che ha introdotto per la prima volta in Europa l’obbligo per le grandi imprese e gli enti di interesse pubblico di rendicontare informazioni non finanziarie relative a tematiche ambientali, sociali, diritti umani, anticorruzione e diversità
Il regolamento SFDR
In stretta connessione con la CSRD si inserisce il Regolamento SFDR, mirato ad aumentare la trasparenza sulla sostenibilità dei prodotti finanziari e a prevenire fenomeni di greenwashing. Lo SFDR impone agli operatori finanziari, incluse le Compagnie assicurative che offrono prodotti di investimento, di fornire informazioni dettagliate su come integrano i fattori ESG nei processi di investimento e sulle caratteristiche “verdi” dei prodotti offerti. In base a questa normativa, i prodotti finanziari devono essere classificati in tre categorie: quelli che non integrano specificamente fattori ESG (prodotti “Articolo 6”), quelli che promuovono caratteristiche ambientali o sociali (prodotti “light green” o “Articolo 8”) e quelli che hanno un obiettivo di investimento sostenibile esplicito (prodotti “dark green” o “Articolo 9”). Le imprese assicurative sono tenute a pubblicare informazioni chiare sulla categorizzazione di ciascun prodotto e su come considerano i principali impatti negativi delle decisioni di investimento sui fattori ESG (i cosiddetti PAI o Principal Adverse Impacts), descrivendo inoltre le strategie di due diligence ESG adottate. Lo SFDR, dunque, opera in parallelo alla CSRD; mentre quest’ultima obbliga le imprese a comunicare il proprio impatto ESG complessivo, lo SFDR impone a gestori e investitori di integrare tali aspetti nelle decisioni e di dare evidenza pubblica del livello di sostenibilità dei prodotti. Di conseguenza, le Compagnie di assicurazione devono non solo adeguarsi a questa regolamentazione per la loro offerta commerciale, ma anche valutare attentamente il profilo ESG delle aziende e degli strumenti finanziari in cui investono le proprie riserve.
Il regolamento Tassonomia
Elemento centrale del framework è il Regolamento Tassonomia[1] che istituisce criteri tecnici dettagliati per stabilire quando un’attività economica può essere considerata eco-sostenibile, sulla base di sei obiettivi ambientali di riferimento: mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai cambiamenti climatici, uso sostenibile delle risorse idriche, transizione verso un’economia circolare, prevenzione e controllo dell’inquinamento, protezione della biodiversità e degli ecosistemi. Le Compagnie di assicurazione sono interessate da questo regolamento in duplice modo: da investitori, perché devono comunicare la quota di investimenti del proprio portafoglio allineata ai criteri della Tassonomia; e da offerenti di prodotti finanziari, perché per i prodotti che dichiarano caratteristiche ecologiche va garantito il rispetto dei criteri tecnici stabiliti. La principale criticità pratica risiede nella difficoltà di reperire dati chiari e affidabili sulla “compatibilità tassonomica” delle imprese sottostanti e degli investimenti. Tale scarsità informativa rende complesso per gli assicuratori valutare e certificare il livello di sostenibilità degli asset detenuti.
[1] Regolamento UE del 18 giugno 2020 n. 852 sulla tassonomia, che definisce i criteri per identificare le attività economiche ecosostenibili
La direttiva CSDDD
Un ulteriore passo in avanti è rappresentato dalla CSDDD, che amplia il perimetro della sostenibilità introducendo obblighi di due diligence ESG lungo l’intera catena del valore delle imprese. Questa direttiva, entrata in vigore nel 2024, impone alle aziende di identificare, prevenire e mitigare gli impatti negativi sui diritti umani e sull’ambiente derivanti dalle proprie operazioni e da quelle dei partner commerciali e fornitori. Le Compagnie assicurative saranno quindi chiamate a valutare i rischi ESG non solo all’interno della propria organizzazione, ma anche nelle pratiche delle aziende assicurate e nei progetti finanziati. In pratica, ciò significa monitorare l’impatto ambientale e sociale dei clienti e garantire che i capitali investiti siano destinati ad attività conformi a standard ESG minimi. La CSDDD introduce inoltre una responsabilità legale più stringente in capo alle imprese, prevedendo possibili sanzioni finanziarie e obblighi risarcitori per i danni derivanti da mancate azioni di due diligence. A differenza di altre normative focalizzate soprattutto sulla trasparenza e la rendicontazione, questa iniziativa impone alle imprese non solo di divulgare informazioni ESG, ma anche di agire attivamente per integrare i principi di sostenibilità nei processi decisionali e operativi, assumendosi responsabilità sui propri impatti lungo tutta la filiera.
Nel loro complesso, queste normative delineano un sistema integrato e interconnesso, che trasforma la disclosure ESG in un elemento centrale della strategia aziendale.
ESG e risk management: l’impatto sul sistema di gestione dei rischi
Integrazione dei rischi ESG nei sistemi di gestione aziendale
Alla luce di questo quadro normativo, la gestione dei rischi rappresenta senza dubbio uno degli ambiti in cui le normative ESG stanno producendo l’impatto più rilevante. Tra le iniziative che maggiormente interessano questo aspetto, ci sono le Linee Guida EBA, che richiedono alle istituzioni finanziarie, incluse le Compagnie di assicurazione, di integrare i rischi ambientali, sociali e di governance all’interno del proprio framework di ESG risk management, adottando una prospettiva temporale ampia che consideri scenari a breve, medio e lungo termine, fino ad almeno dieci anni.
Un principio che si inserisce in continuità con quanto previsto dalla Direttiva Solvency II e rafforzato dalla sua recente revisione (Direttiva UE 2025/2), che ha ampliato l’articolo 44 introducendo l’obbligo per le imprese di predisporre piani di sostenibilità con obiettivi misurabili e una gestione strutturata dei rischi finanziari ESG. Tali piani devono risultare coerenti con le linee guida europee e proporzionati al profilo di rischio effettivo della compagnia.
La Review interviene anche sull’ORSA, richiedendo valutazioni prospettiche dell’esposizione ai cambiamenti climatici; qualora il rischio sia considerato rilevante, le imprese devono includere almeno due scenari di lungo periodo: uno in cui l’aumento della temperatura globale resta entro i +2°C, e uno in cui tale soglia viene superata. Infine, il SFCR viene aggiornato per includere informazioni specifiche in materia di sostenibilità, rafforzando gli obblighi di trasparenza verso stakeholder e autorità di vigilanza, in linea con la crescente richiesta di disclosure ESG.
Interazione dei rischi ESG con i rischi finanziari tradizionali
I fattori ESG non si presentano come rischi autonomi o isolati, ma operano trasversalmente, influenzando e amplificando i rischi finanziari tradizionali. Ad esempio, l’esposizione a settori ad alto impatto ambientale, come l’industria estrattiva o quella pesantemente dipendente dai combustibili fossili, può accrescere il rischio di credito per le Compagnie, aumentando la probabilità di deterioramento della qualità degli attivi.
Allo stesso modo, la crescente volatilità legata alla transizione energetica, alle politiche ambientali e agli sviluppi tecnologici espone le imprese a rischi di mercato sempre più difficili da prevedere e gestire. Sul fronte reputazionale, i casi di greenwashing, le controversie sociali e le pratiche di governance non allineate agli standard internazionali di sostenibilità possono tradursi in un serio danno d’immagine, con ripercussioni sui rapporti con investitori, clienti e stakeholder.
A tutto questo si aggiunge un aumento del rischio legale e di compliance, determinato dall’irrigidimento delle normative europee sulla ESG due diligence e sulla trasparenza, che impone alle assicurazioni una vigilanza costante sulle proprie attività e su quelle delle controparti.
Evidenze empiriche e necessità di migliorare i sistemi previsionali
Questa complessità crescente trova conferma anche in recenti studi empirici[1] che hanno dimostrato come una buona performance ESG contribuisca in modo concreto a ridurre la probabilità di default delle Compagnie assicurative, sia nel breve che nel lungo termine. La ricerca condotta da Palmieri, Miani e Mantovani (2024) evidenzia come l’integrazione sistematica dei fattori ESG nei processi di selezione dei rischi, nelle politiche di underwriting e nelle decisioni di investimento, rafforzi la solidità patrimoniale delle imprese e migliori la loro capacità di far fronte agli shock sistemici. Questo effetto di stabilizzazione risulta particolarmente rilevante in un contesto in cui le Compagnie sono chiamate a gestire sfide complesse e interconnesse.
La crescente richiesta di stress test climatici e l’obbligo di valutare scenari ESG su orizzonti temporali estesi spingono il settore assicurativo a dotarsi di modelli previsionali più sofisticati, capaci di anticipare l’evoluzione dei rischi e di integrare variabili ambientali, sociali e di governance nei propri algoritmi di analisi. Tuttavia, la carenza di dati standardizzati e affidabili continua a rappresentare un ostacolo significativo, rendendo ancora più urgente l’investimento in sistemi di raccolta e gestione delle informazioni, senza i quali una valutazione puntuale dei rischi ESG risulta di fatto impossibile.
[1] Palmieri E., Miani S., Mantovani M. (2024), Insurance Firms and ESG policies: the effect on default risk effect and riskiness
ESG, governance e modello 231
Un’altra area fortemente interessata dalla spinta normativa verso l’integrazione dei fattori ESG è la governance delle Compagnie assicurative, che si trova ad affrontare una trasformazione dei modelli organizzativi e dei sistemi di controllo. In un contesto in cui la sostenibilità sta diventando una componente imprescindibile della strategia aziendale, la governance non può più limitarsi a garantire la compliance normativa, ma deve condurre una gestione consapevole dei rischi e delle opportunità legate alla transizione sostenibile. La crescente complessità normativa richiede strutture organizzative in grado di garantire trasparenza, accountability e capacità di governo dei fenomeni ESG. Non si tratta solo di adeguare le procedure interne, ma di ripensare il ruolo stesso degli organi di amministrazione e controllo, che devono assumersi la responsabilità di valutare l’impatto ambientale e sociale delle decisioni strategiche. Questo nuovo approccio si traduce nella necessità di rafforzare i presidi di governance e di integrare la sostenibilità nei processi decisionali e nella reportistica aziendale.
Tra gli strumenti più efficaci per accompagnare questa evoluzione, nominiamo il modello di organizzazione, gestione e controllo (ex d.lgs. 231/2001), che si sta affermando come strumento ideale per coniugare compliance e sostenibilità. Il documento di ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti[1] evidenzia come il modello 231, nato per prevenire la commissione di reati, possa oggi rappresentare un efficace alleato nella gestione dei rischi ESG. Grazie alla sua struttura basata sulla mappatura delle aree di rischio e sulla definizione di protocolli e controlli, il modello si presta ad accogliere anche i nuovi rischi ambientali, sociali e di governance, contribuendo a rafforzare la capacità delle imprese di anticipare e gestire potenziali criticità. Il valore aggiunto del modello 231 risiede nella possibilità di costruire una compliance integrata, in cui la sostenibilità non sia vista come un obbligo aggiuntivo ma come parte integrante della cultura aziendale e del sistema dei controlli interni. In questo quadro, l’Organismo di Vigilanza assume un ruolo strategico non solo nella prevenzione dei reati, ma anche nel monitoraggio dei rischi ESG e nella promozione di comportamenti virtuosi. La tracciabilità dei processi e la responsabilizzazione delle diverse funzioni aziendali consentono di garantire la legalità formale, ma anche la coerenza sostanziale delle scelte aziendali con gli obiettivi di sostenibilità.
L’adozione di un modello 231 aggiornato in chiave ESG diventa quindi un’opportunità per rafforzare la governance e per costruire un vantaggio competitivo, soprattutto in un settore come quello assicurativo, dove la fiducia degli stakeholder è un asset fondamentale.
[1] Fondazione Nazionale dei Commercialisti (2024), Modello 231 e fattori ESG: l’importanza di una virtuosa connessione
Prodotti sostenibili nel settore assicurativo
L’attenzione alla sostenibilità non si riflette solo nei processi interni di gestione del rischio e di governance, ma anche nell’offerta di prodotti assicurativi. Negli ultimi anni le Compagnie hanno iniziato a sviluppare prodotti sostenibili, ossia soluzioni assicurative che incorporano criteri ESG sia nella struttura finanziaria sia nelle finalità di copertura. In particolare, nel ramo vita e investimento, sono nate polizze collegate a fondi con caratteristiche ESG (come le polizze unit-linked o multiramo che investono in fondi “verdi”). Nel ramo danni si vedono iniziative come polizze auto scontate per veicoli elettrici, coperture per impianti di energie rinnovabili o prodotti che incentivano comportamenti virtuosi (ad esempio, assicurazioni casa con sconti se si adottano misure di efficientamento energetico). Questi prodotti rispondono alla crescente domanda di investimenti e coperture responsabili, permettendo ai clienti di allineare le proprie scelte assicurative ai valori di sostenibilità.
Il contesto normativo ha giocato un ruolo centrale nello sviluppo e nella regolamentazione dei prodotti assicurativi sostenibili. Oltre agli interventi prudenziali e informativi già menzionati, il legislatore europeo ha agito anche sulle regole di distribuzione e governo dei prodotti, modificando la Direttiva IDD[1] e il Regolamento sulla POG[2]. A partire dal 2022, gli assicuratori sono tenuti a considerare gli obiettivi di sostenibilità dei clienti nella definizione del mercato di riferimento e nella progettazione dei prodotti. L’integrazione dei fattori ESG nella fase di collocamento, introdotta dal Regolamento Delegato (UE) 2021/1257, ha l’obiettivo di ridurre il rischio di greenwashing e rafforzare la tutela del consumatore. In parallelo, la SFDR, già citata in precedenza, disciplina la classificazione e la trasparenza dei prodotti finanziari in base al loro grado di sostenibilità. In particolare, l’articolo 8 del SFDR riguarda i prodotti che promuovono caratteristiche ambientali o sociali (i cosiddetti “light green”), mentre l’articolo 9 si riferisce ai prodotti che perseguono un obiettivo di investimento sostenibile (“dark green”). Attualmente, la maggior parte delle polizze vita con caratteristiche ESG offerte in Italia rientra nella classificazione dell’articolo 8, mentre risultano ancora assenti prodotti conformi all’articolo 9. Secondo IVASS[3], nel 2023 il 92% delle polizze ESG era classificato come Articolo 8 e nessuna come Articolo 9, segnalando un orientamento del mercato verso soluzioni che integrano elementi ESG senza fissare obiettivi sostenibili espliciti. Questo dato indica un approccio ancora prudente; le Compagnie tendono a promuovere aspetti ESG (ad esempio investendo parte dei premi in fondi ESG o offrendo benefit sociali), ma raramente strutturano prodotti la cui performance sia valutata esclusivamente in termini di impatto sostenibile.
Anche il Regolamento Tassonomia influisce sui prodotti assicurativi sostenibili, in particolare su quelli di investimento. Se un’assicurazione vita commercializza una polizza che si dichiara “verde”, dovrà verificare e comunicare in che misura gli investimenti sottostanti rispettano i criteri della Tassonomia UE. Questo meccanismo assicura che i requisiti ambientali non rimangano slogan, ma siano misurati con parametri ufficiali, prevenendo il rischio che prodotti venduti come sostenibili in realtà finanzino attività poco allineate alla transizione ecologica.
In Italia, l’IVASS ha dedicato particolare attenzione alla tematica dei prodotti ESG, affiancando all’adeguamento normativo un’azione di monitoraggio sul campo. Nell’indagine tematica del 202318, ha analizzato le polizze di investimento con caratteristiche ESG, coinvolgendo 18 Compagnie per valutarne la struttura e le modalità di presentazione al pubblico. Dall’indagine è emerso che le Compagnie italiane si stanno muovendo attivamente e l’offerta di prodotti sostenibili è già ampia (soprattutto polizze multiramo, che combinano gestione separata e unit-linked) e, in generale, le Compagnie hanno integrato le tematiche ESG nei propri processi di POG e nelle politiche distributive. Ciò significa che molte imprese, anticipando i requisiti europei, hanno rivisto le proprie procedure di progettazione prodotto e di vendita, incorporando parametri ESG (ad esempio, check-list ESG nei comitati prodotti, formazione della rete di vendita sulle preferenze di sostenibilità dei clienti, etc.).
[1] Direttiva UE del 20 gennaio 2016 n. 97 (IDD – Insurance Distribution Directive), che disciplina la distribuzione dei prodotti assicurativi nell’Unione Europea, con l’obiettivo di garantire una maggiore tutela del consumatore e condizioni uniformi di accesso al mercato
[2] Regolamento Delegato (UE) del 21 settembre 2017 n. 2358, che integra la Direttiva 2016/97 (IDD) per quanto riguarda i requisiti in materia di governo e controllo del prodotto (Product Oversight and Governance – POG) da parte delle imprese di assicurazione e dei distributori
[3] IVASS (marzo 2023), Analisi delle polizze IBIPs con caratteristiche ESG
FAQ ESG nelle assicurazioni
1. Che cosa significa ESG nelle assicurazioni?
ESG è l’acronimo di Environmental, Social and Governance. Nel settore assicurativo, rappresenta l’insieme dei criteri ambientali, sociali e di governance che le compagnie devono integrare nelle strategie, nei prodotti e nei processi decisionali.
2. Quali obblighi ESG devono rispettare le compagnie assicurative?
Le assicurazioni devono conformarsi a normative come la CSRD (per la rendicontazione ESG), la SFDR (per la classificazione dei prodotti finanziari) e la CSDDD (per la due diligence nella filiera). Questi obblighi includono la trasparenza, la gestione del rischio e il monitoraggio degli impatti sociali e ambientali.
3. Cos’è la disclosure ESG?
La disclosure ESG è la comunicazione trasparente e standardizzata delle informazioni relative ai rischi e impatti ambientali, sociali e di governance di un’impresa. È diventata un requisito obbligatorio per molte compagnie, da includere nei bilanci annuali.
4. Cosa significa ESG risk management?
L’ESG risk management consiste nell’integrazione dei rischi legati a sostenibilità, clima, governance e aspetti sociali all’interno dei processi di valutazione, underwriting e controllo dei rischi tipici delle assicurazioni.
5. In cosa consiste la due diligence ESG?
La due diligence ESG è l’attività di identificazione, valutazione e mitigazione degli impatti negativi causati (o potenzialmente causabili) da un’azienda o dai suoi fornitori su ambiente e diritti umani. È obbligatoria con l’entrata in vigore della direttiva CSDDD.
Conclusione
Il settore assicurativo si trova oggi al centro di una trasformazione epocale, in cui la sostenibilità diventa parte integrante del business model e non più un semplice elemento di contorno. L’ampio e complesso framework normativo emerso negli ultimi anni sta certamente imponendo sfide importanti alle Compagnie, che sono chiamate ad adeguare processi interni, competenze e strategie. Tuttavia, queste sfide rappresentano anche una straordinaria opportunità di evoluzione per l’intero settore.
In qualità di grandi investitori istituzionali, gli assicuratori possono indirizzare enormi flussi di capitali verso progetti sostenibili, contribuendo al finanziamento della transizione ecologica. Come gestori di rischi, possono sviluppare soluzioni innovative per coprire i nuovi rischi climatici e pandemici, supportando la società nell’adattamento ai cambiamenti in atto. Inoltre, attraverso le proprie politiche, le Compagnie possono incentivare comportamenti virtuosi, premiando con condizioni favorevoli le aziende assicurate che adottano pratiche ESG o i clienti retail attenti all’ambiente. In tal modo, il settore assicurativo diventa un motore del cambiamento, interpretando le nuove normative come leve per creare valore condiviso.
Hai bisogno di supporto nella conformità ESG?
Affidati a CA Consulting, partner specializzato in ESG compliance per assicurazioni. Ti aiutiamo a rispettare le normative (CSRD, SFDR, CSDDD), migliorare la tua disclosure ESG, integrare l’ESG risk management e sviluppare strategie sostenibili ad alto impatto.
Richiedi ora una consulenza personalizzata.
Dott.ssa Francesca Novati, Partner di Ca&Co
Dott.ssa Sofia Berretta, Senior Consultant di Ca&Co
Dott. Youssef Bouaziz, Junior Consultant di Ca&Co