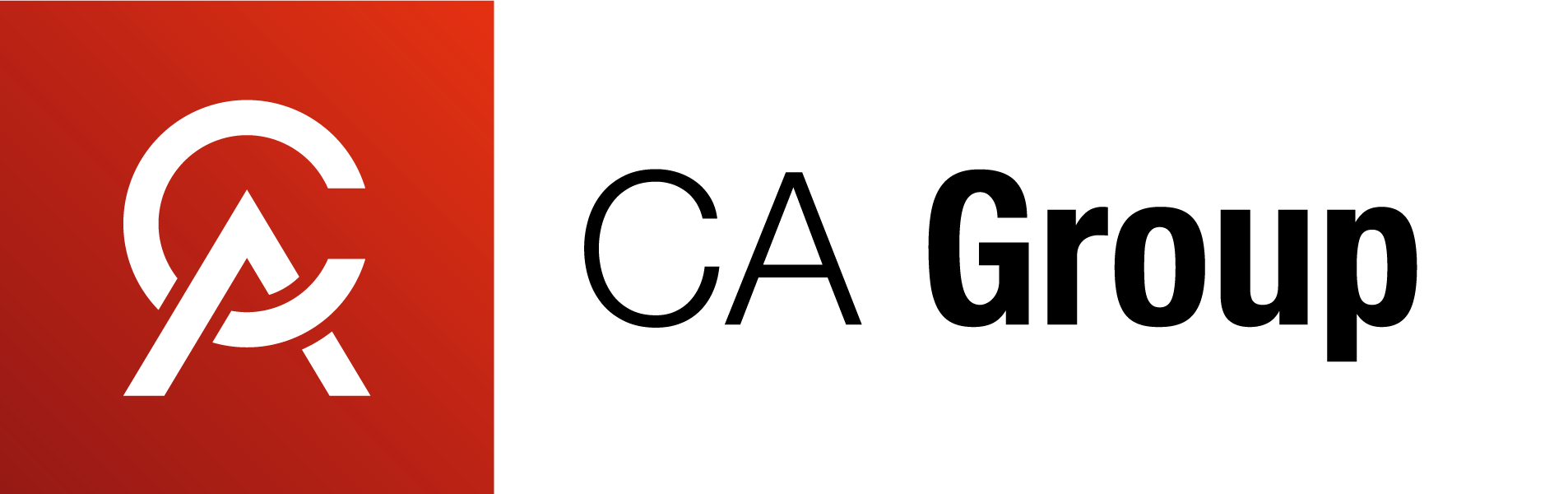Il caso delle multiproprietà turnarie
Gli atti di rinuncia alla proprietà immobiliare sono ritornati di grande attualità negli ultimi anni soprattutto in relazione al caso delle multiproprietà turnarie, particolarmente diffusesi tra gli anni 70 e 90, ritornate di attualità a seguito della perdita del loro valore intrinseco che si è accompagnato ad un aumento esponenziale delle spese di gestione a carico dei proprietari. Il presente contributo fa il punto in diritto del concetto di rinuncia abdicativa della proprietà immobiliare e affronta lo stato attuale della giurisprudenza, sempre più coinvolta in decisioni riguardanti rinunce di proprietà all’interno di complessi gestiti nella forma della multiproprietà, di cui si cerca di fornire definizioni e categorie di massima.
Tipologie di multiproprietà immobiliare
Il coinvolgimento sempre maggiore del Giudice ordinario per controversie inerenti alle multiproprietà trae origine da due cause principali (la perdita di valore e l’aumento di costi di gestione), ciascuna intrinsecamente collegata alle due principali tipologie di utilizzo turnario della proprietà immobiliare:
- La multiproprietà Reale
- La multiproprietà Contrattuale
Innanzitutto è importante dare una definizione del concetto di Multiproprietà immobiliare, che ha rappresentato a partire dagli anni 70 e fino a tutto gli anni 90 del secolo scorso, un fenomeno economico di rilevantissime proporzioni, oltre che protagonista di casi emblematici di truffe e fallimenti che hanno creato danni ingentissimi al tessuto economico della “middle class” italiana, ammaliata dalla possibilità di poter godere l’utilizzo di immobili in località di vacanza di grande bellezza e attrattività.
La multiproprietà è nella sostanza un istituto immobiliare che si caratterizza per il diritto di godimento turnario di un medesimo bene da parte di una pluralità di soggetti. I soggetti convolti in tale utilizzo turnario possono anche non essere direttamente proprietari del bene immobile, ma solamente di godere del diritto di utilizzo temporaneo, in forza di un contratto stipulato con un terzo proprietario.
Da tale distinzione deriva l’individuazione di due distinte tipologie di multiproprietà: Reale e Contrattuale.
La differenza fondamentale delle due tipologie risiede nel tipo di diritto a cui è agganciata la possibilità di godimento turnario della proprietà:
- derivante nel primo caso dall’acquisto di una porzione di un immobile univocamente individuato (la cui proprietà è nei fatti una comunione con altri comproprietari, regolata dagli articoli 1100 e seguenti del Codice civile);
- regolata, nel secondo caso, da un vincolo contrattuale a prestazioni corrispettive stipulato con un terzo proprietario, senza che vi sia un trasferimento di un diritto reale di godimento.
Come sarà approfondito nel corso del presente contributo, gli atti di abdicazione della proprietà possono avere impatto giuridico sul primo tipo di multiproprietà, in quanto caratterizzato dalla presenza di una comunione legale, ma non sul secondo per il quale valgono le regole sul recesso contrattuale e sulle leggi speciali (comunitarie e nazionali) che hanno tentato di regolamentare il fenomeno, imponendo vincoli soprattutto per quanto riguarda le necessarie clausole di recesso.
Caratteristiche della multiproprietà reale
La multiproprietà reale basa il diritto di godimento turnario su un duplice accordo contrattuale tra il cedente del bene ed il cessionario:
- contratto di compravendita di una quota del bene oggetto del godimento turnario. Gli acquirenti diventano a tutti gli effetti proprietari, in comunione indivisa ai sensi dell’art. 1100 del c.c., dell’immobile che sarà oggetto di utilizzo tra i vari partecipanti. Normalmente negli atti di compravendita di queste quote immobiliari la presunzione prevista dal primo comma dell’art. 1102 viene superata da precise disposizioni contrattuali, che assegnano quote diverse a seconda della quantità di periodo unitario di utilizzo di cui si richiede l’acquisto e quindi in aggancio stretto con il secondo contratto stipulato;
- contratto di utilizzo turnario. Stipulato quale impegno a rispettare una più generale tabella regolamentare di utilizzi, normalmente approvata al momento di costruzione dei complessi vacanzieri poi offerti in multiproprietà ed inserito nei regolamenti condominiali. Un esempio per tutti è quello della costruzione di resort o residence offerti in vendita ai singoli utilizzatori turnari, su cui viene imposto un regolamento condominiale che, al suo interno, individua decadi o settimane nel corso dell’anno associate alla singola quota di comunione acquistata dal cessionario del bene. Di norma l’individuazione del periodo di utilizzo corrisponde ad una precisa quota di comproprietà mai ulteriormente frazionabile. Non infrequente il caso di regolamenti condominiali che individuano, come unità minima di proprietà, la decade di ogni singolo mese consentendo di acquistare una sola o multipli di essa. Tale divisione in decadi (stessa identica logica può essere applicata ad una divisione settimanale) corrisponderà all’unità minima di proprietà immobiliare acquistabile: un trentaseiesimo di proprietà in caso di divisione in decadi ovvero un cinquantaduesimo in caso di unità settimanali. L’acquirente che decidesse di acquistare una quota di multiproprietà nella forma della proprietà reale, diverrebbe proprietario di un solo trentaseiesimo o di un cinquantaduesimo dell’unità immobiliare stessa. Le tabelle condominiali così costituite riportano sempre tabelle millesimali che assegnano un numero di millesimi alle singole unità di utilizzo (decade o settimana), calcolato in base ad una precisa stagionalità di utilizzo: ad una decade del mese di agosto in località di mare o di montagna, quindi in alta stagione, sarà assegnato un numero di millesimi superiore rispetto ad una medesima decade o settimana in bassa stagione.
Da questa prima definizione possono essere fatte le prime deduzioni:
- le singole decadi o settimana di utilizzo non contribuiscono allo stesso modo al mantenimento della cosa comune. Il proprietario di alta stagione ha costi maggiori di un comproprietario di bassa stagione.
- Il frazionamento in decadi o settimane (frazionamenti giornalieri renderebbero la gestione degli immobili pressoché impossibili), genera aberrazioni condominiali importanti, per cui non solo deve essere gestita la cosa comune, ma anche ogni singola unità immobiliare è nei fatti una ulteriore sotto-comunione, che deve rispettare le stesse regole della comunione ordinaria sovrastante.
- Il passaggio generazionale moltiplica i comproprietari nelle persone degli eredi coinvolti. Se il primo acquirente è effettivamente proprietario di una quota immobiliare, al momento del decesso i chiamati all’eredità diverranno proprietari della quota del de cuius, con complicazioni enormi legate alla indivisibilità (contrattuale) della singola quota di utilizzo. Se il de cuius era proprietario di una singola decade di utilizzo, quindi di un trentaseiesimo dell’immobile non ulteriormente divisibile, tra gli eredi si genererà una ulteriore sotto-comunione indivisa avente ad oggetto la singola decade o settimana. L’effetto del passare degli anni su questa impostazione è dirompente: in complessi vacanzieri inizialmente venduti a poche decine di acquirenti, il passare dei decenni dagli anni 70 ad oggi, coinvolge potenzialmente centinaia di soggetti giuridici, tutti partecipanti al condominio costituito su tutto il complesso, a gruppi partecipanti alle singole comunioni immobiliari, in gruppi più ristretti a potenziali comunioni ereditarie della singola unità di utilizzo turnario. Tale impatto ha come ulteriore conseguenza che la gestione della maggior parte dei complessi organizzati in questo modo è sovente governata da un complesso sistema di deleghe ed un basso quorum deliberativo, il cui esito è poi il generale disinteresse alla cosa comune dei più e l’aumento spropositato della spesa condominiale, integralmente sotto il controllo di élite ristrette di proprietari interessati.
Facilmente si comprende dunque che questa prima tipologia di multiproprietà, peraltro la più antica e diffusa, sia nei fatti una iattura per chi ne fa parte volontariamente e per chi ne è stato coinvolto per uno o più passaggi ereditari. La globalizzazione, la possibilità di viaggiare a costi più bassi di un tempo, la possibilità di prenotare via internet alloggi e vacanze in qualsiasi parte del mondo a basso costo, ha reso la multiproprietà uno strumento e una proposta turistica assolutamente non conveniente nel mondo moderno.
In particolare, rileviamo:
- il sostanziale azzeramento del valore di queste quote immobiliari, sostanzialmente invendibili, o scambiabili ad un prezzo negativo;
- l’aumento esponenziale dei costi di gestione delle strutture (i comproprietari si disinteressano del loro mantenimento che, a causa della anzianità delle strutture e dell’azzeramento dei prezzi di mercato, sono sempre meno incentivati ad investire nella cosa comune per mantenerne il valore, innescando un processo di selezione avversa che ha come esito la rovina definitiva delle strutture);
- l’aumento esponenziale delle morosità condominiali, in conseguenza del crollo dei valori già segnalato.
A tal proposito basti pensare che una quota (decade o settimana) di utilizzo turnario in multiproprietà reale compravenduto nei primi anni 2000 mediamente a € 10.000, viene oggi (nel migliore dei casi) ceduto a € 2.500. In alcune strutture del centro Italia meno rinomate si sono presentate situazioni di cessione a prezzo zero, con accollo da parte del cedente del costo di trasferimento della proprietà (prezzo negativo). In tale caso quindi la titolarità del diritto di proprietà turnaria rappresenta unicamente un debito costante nei confronti dei vari condomìni che non può trovare quasi mai una valorizzazione soddisfacente.
Ulteriore aggravio delle difficoltà di valorizzazione di questi beni è intervenuto recentemente con l’introduzione di regole più severe per accedere ad affitti brevi. La necessità di dotarsi di numeri identificativi degli immobili, per poter proporre l’utilizzo delle unità turnarie su piattaforme on line, è solo uno degli ostacoli da superare per poter mettere a reddito queste proprietà. Spesso e volentieri tra i comproprietari non è possibile superare le decisioni relative a chi debba chiedere le autorizzazioni per l’affitto del bene, oppure superare l’ostacolo di un comproprietario dissenziente in quanto non d’accordo all’utilizzo del suo immobile da parte di terzi estranei cui un altro comproprietario può decidere di affittare.
La sostanza della multiproprietà immobiliare è quella di un sistema di utilizzo di beni immobili che nel tempo è destinato ad essere ingestibile e a giungere a situazioni, evitabili solo in caso di coinvolgimento di pochi soggetti illuminati, di totale impossibilità di decisione, che aumenta e accelera se possibile il deperimento del bene e del suo contenuto (basti pensare agli arredamenti, agli impianti idraulici e idrici, la cui manutenzione è lasciata alla decisione di tutti gli utilizzatori della singola comunione indivisa, quasi mai in accordo e armonia).
Funzionamento della multiproprietà contrattuale
L’impostazione puramente contrattuale della proprietà turnaria è quella decisamente più moderna e che ha cercato, soprattutto nel corso degli anni Novanta dello scorso secolo, di superare le drammatiche disfunzioni della condivisione turnaria di un diritto di proprietà reale immobiliare.
In questo ambito l’acquirente non acquista alcuna proprietà immobiliare, ma solo il diritto di godimento di una singola unità immobiliare per un determinato periodo (settimana o decade). La proprietà immobiliare rimane quindi saldamente nelle mani di un terzo fornitore che non cede la proprietà del bene, ma solo il diritto di godimento. Tali contratti hanno interessato soprattutto strutture alberghiere e turistico-ricettive.
La tipica struttura contrattuale è l’acquisto del godimento turnario del periodo con contestuale accollo delle spese di mantenimento della struttura sulla base di una tabella millesimale, calcolata con i medesimi criteri sopra descritti per la multiproprietà reale. Unità di utilizzo in alta stagione sono mediamente associate a un numero di millesimi superiore rispetto al medesimo diritto di godimento per un periodo di bassa stagione.
Questa impostazione consentiva un maggiore appeal nei confronti del pubblico e quindi ha permesso una maggiore diffusione di questi tipi di contratti. Il mero rapporto contrattuale, per esempio, consentiva ai gestori di proporre scambi di periodi con altri utenti in diverse strutture gestite in tutto il mondo. Un utilizzatore di una settimana di vacanza in Alta Badia, secondo procedure interne ai vari circuiti con tempi e scadenze prefissati, poteva liberare la sua unità di utilizzo al mercato degli altri comproprietari e “scambiare” la sua settimana con un utilizzatore di base in Sardegna o addirittura ai Caraibi. I gestori delle strutture gestendo gli scambi promettevano, sostenendo il costo di una singola unità di godimento immobiliare, di poter fare la propria vacanza nella settimana acquistata in strutture diverse. Bisogna riconoscere che tale impostazione per qualche lustro ha funzionato, quanto meno fino all’avvento delle piattaforme di prenotazione on line, che hanno reso evidente che l’acquisto definitivo di periodi di vacanza non era più necessario, data l’apertura del mercato turistico mondiale alla rete e quindi al mercato dei vacanzieri di tutto il mondo, con offerte sostanzialmente illimitate.
La diffusione enorme di questa impostazione, che ha fatto la fortuna di svariati operatori alberghieri, è stata oggetto di interesse del legislatore comunitario e nazionale in diverse occasioni, le più importanti norme in materia sono state
- Direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26.10.1994, relativa alla tutela del consumatore per taluni aspetti dei contratti relativi all’acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili. L’intervento ha tentato di assegnare agli utilizzatori alcuni diritti applicabili in tutta l’U.E. al fine di fissare un regolamento uniforme per la loro tutela. La direttiva ha introdotto una normativa quadro destinata a vincolare i singoli legislatori europei nell’adozione di una regolamentazione interna, atta a proteggere il consumatore nei rapporti negoziali aventi ad oggetto l’acquisto del diritto di godimento a tempo parziale secondo tre elementi fondanti:
- l’obbligo per il venditore di fornire tutte le informazioni tecniche e giuridiche, le più dettagliate possibile, inerenti all’operazione da perfezionare nella fase della sua trattativa;
- la possibilità per l’acquirente di recedere, anche ad nutum, dal contratto;
- il divieto per il venditore di esigere dall’acquirente somme di denaro a qualsiasi titolo fino alla scadenza del termine concesso per l’esercizio del diritto di recesso.
- Decreto legislativo 9 novembre 1998 numero 427, attuativo della suindicata direttiva europea 94/47/CE. Questo decreto introduce nel nostro ordinamento una importante serie di definizioni e di regole di funzionamento della multiproprietà contrattuale, che tuttavia non hanno salvato tutti i contratti precedenti, spesso privi degli elementi essenziali di validità individuati dal D.Lgs 497/1998. A titolo esemplificativo e non esaustivo il citato decreto
- introduce la definizione di contratto di multiproprietà. All’articolo 1, lett. a, del D. Lgs. n. 427/1998, infatti, si affermava che per tale si intendeva un contratto della durata di almeno tre anni con il quale, verso pagamento di un prezzo globale, veniva costituito o trasferito, o si prometteva di costituire o trasferire, direttamente o indirettamente, un diritto reale ovvero un altro diritto avente ad oggetto il godimento su uno o più beni immobili, per un periodo determinato o determinabile dell’anno non inferiore ad una settimana.
- Introduce l’obbligo di consegna di un documento informativo ad ogni persona che richieda notizie o delucidazioni sul bene immobile. Il venditore in particolare è tenuto a rendere informazioni complete circa i seguenti elementi: a) il diritto oggetto del contratto, con specificazione della natura e delle condizioni di esercizio di tale diritto nello Stato in cui è situato l’immobile; se tali ultime condizioni sono soddisfatte o, in caso contrario, quali occorre soddisfare; b) l’identità e il domicilio del venditore, con specificazione della sua qualità giuridica, l’identità e il domicilio del proprietario; c) nel caso in cui l’immobile sia determinato, la descrizione dello stesso e la sua ubicazione; nel caso in cui invece l’immobile non sia ancora determinato bisogna fornire gli estremi della concessione edilizia e delle leggi regionali che regolano l’uso dell’immobile con destinazione turistico – ricettiva e, per gli immobili situati all’estero, gli estremi degli atti che garantiscano la loro conformità alle prescrizioni vigenti in materia, nonché lo stato di avanzamento dei lavori di costruzione dell’immobile e la data entro la quale è prevedibile il completamento degli stessi; inoltre è da aggiungere anche lo stato di avanzamento dei lavori relativi ai servizi, quali il collegamento alla rete di distribuzione di gas, elettricità, acqua e telefono ed infine, in caso di mancato completamento dell’immobile, le garanzia relative al rimborso dei pagamenti già effettuati e le modalità di applicazioni di queste garanzie; d) i servizi comuni ai quali l’acquirente ha o avrà accesso, quali luce, acqua, manutenzione, raccolta di rifiuti con le relative condizioni di utilizzazione e le strutture comuni alle quali l’acquirente ha o avrà accesso, quali piscina, sauna ed altre con le relative condizioni di utilizzazione, con in aggiunta le norme applicabili in materia di manutenzione e riparazione dell’immobile, nonché in materia di amministrazione e gestione dello stesso; e) il prezzo globale, comprensivo di iva, che l’acquirente verserà quale corrispettivo; la stima dell’importo delle spese, a carico dell’acquirente, per l’utilizzazione dei servizi e delle strutture comuni e la base di calcolo dell’importo degli oneri connessi all’occupazione dell’immobile da parte dell’acquirente, delle tasse e imposte, delle spese amministrative accessorie per la gestione, la manutenzione e la riparazione, nonché le eventuali spese di trascrizione del contratto; f) le informazioni circa il diritto di recesso dal contratto con l’indicazione degli elementi identificativi della persona alla quale deve essere comunicato il recesso stesso, precisando le modalità della comunicazione e l’importo complessivo delle spese, specificando quelle che l’acquirente in caso di recesso è tenuto a rimborsare; g) le modalità per ottenere ulteriori informazioni.
- Obbligatoria introduzione del diritto di recesso contrattuale dell’acquirente, non previsto in precedenza.
- D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, c. d. Codice del Consumo (abrogativo del D. Lgs. 9 novembre 1998 n. 427); D.Lgs. n. 79/2011, c.d. Codice del turismo. In particolare quest’ultimo provvedimento ha recepito la disciplina europea modificandola in maniera sostanziale agli articoli 69 e ss che hanno fornito definizioni più precise in merito ai contratti definitivi e preliminari, oltre che imponendo regole precise per l’esercizio del diritto di recesso dell’acquirente che, si ribadisce, prima dell’intervento normativo del 1998, non era previsto nei contratti di multiproprietà non reale. Le modifiche introdotte dal Codice del Consumo hanno avuto ad oggetto (oltre ad alcune correzioni formali) la definizione di acquirente (che richiama espressamente la nozione di “consumatore”), la disciplina del prezzo (che fa riferimento alla globalità degli esborsi che l’acquirente è chiamato a sopportare), la espressa salvaguardia nell’applicazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché il coordinamento con le altre disposizioni del Codice contenenti disposizioni eventualmente più favorevoli al consumatore, così pervenendosi ad un risultato apprezzabile nella riconduzione della materia alla sistematicità della disciplina dei contratti del consumo. L’entrata in vigore del D.Lgs. n. 79/2011, c.d. Codice del turismo, ha apportato delle novità alla preesistente disciplina contemplata dal Codice del consumo, adeguando il nostro ordinamento alla direttiva 2008/122/CE, per effetto della quale veniva sollecitato, agli Stati membri, un intervento mirato a colmare determinate lacune presenti all’interno degli ordinamenti giuridici al fine di armonizzare l’intero complesso normativo disponente la commercializzazione e la vendita della multiproprietà.
Numerosi sono stati gli interventi della Giurisprudenza in materia di multiproprietà contrattuale, per contratti antecedenti a questi interventi normativi, tutti viziati da gravi irregolarità nella formazione del consenso dell’acquirente alla firma di contratti. Alcune tra le sentenze più importanti:
Trib. Parma, sentenza n. 995 del 7 luglio 2006: il recesso, per legge, non può essere condizionato da alcuna penalità, oltre tutto, nel caso di specie, di ammontare evidentemente spropositato.
Trib. Firenze, sentenza n. 1481 del 2 aprile 2004: è nullo il contratto di acquisto di un immobile in multiproprietà che l’acquirente è stato indotto a stipulare per effetto di false dichiarazioni della società venditrice, quando il contratto sia privo degli elementi prescritti dall’art. 3 del D.Lgs. n. 427/1998.
Autorità garante per la concorrenza e il mercato, provv. n. 10319 del 28 gennaio 2002: se l’atto di acquisto di un immobile in multiproprietà comprende la possibilità di scambiarlo con altri immobili che però non si trovano in località analoghe a quella prescelta, l’offerta è ingannevole.
Trib. Chiavari, sentenza n. 389 dell’8 agosto 2000: le garanzie previste a favore dell’acquirente di multiproprietà dal D.Lgs. n. 427/1998 devono essere applicate anche al contratto con cui viene venduto un immobile che si trova al di fuori della Unione europea, quando le parti nell’atto di vendita non hanno previsto di disciplinare il contratto secondo una legge diversa da quella italiana.
I citati casi costituiscono alcuni pochi esempi di una giurisprudenza più vasta che ha sanzionato comportamenti di operatori del settore evidentemente scorretti, precedenti al 1998, anno che costituisce uno spartiacque normativo tra un periodo di deregolamentazione totale ed un periodo successivo di maggiore monitoraggio e, soprattutto, di riconoscimento di diritti pieni al consumatore coinvolto in contratti di godimento turnario. Ad oggi l’azzeramento del valore delle quote di godimento turnario contrattuale è facilmente verificabile on line, nelle medesime proporzioni drammatiche della perdita di valore della multiproprietà reale. Si rilevano casi di acquisto di singola settimana in strutture alberghiere del sud Italia al prezzo di 25 milioni di lire nei primi anni Novanta, proposti attualmente in vendita oggi a prezzo zero o negativo (come per la multiproprietà reale).
Stato attuale del mercato delle multiproprietà
Appare evidente che ad oggi non esiste più un vero e proprio mercato di scambio di quote di comproprietà turnaria immobiliare, ovvero di contratti di godimento turnario. Questi tipi di diritti sono stati sostituiti da modalità di fruizione di servizi turistici molto più convenienti e dinamici, che consentono di viaggiare in comodità e senza vincoli.
Evidentemente anche gli operatori di settore sono ben consapevoli di questa situazione di totale stallo e perdita di valore, ma sono anche consapevoli di un altro aspetto ben più interessante. Se da un lato, infatti, l’utilizzo turnario è divenuto negli anni un istituto totalmente obsoleto e antieconomico, le strutture in qui questi diritti possono essere esercitati, invece, continuano ad avere un cospicuo valore immobiliare, oltre che potenzialità enormi di sviluppo nel mercato del turismo, soprattutto in Italia. In particolare, gli effetti collaterali negativi della Multiproprietà sugli utilizzatori, soprattutto in termini di costi di gestione, lasciano ampi spazi di rastrellamento di quote di utilizzo turnario, finalizzate all’acquisizione di intere strutture alberghiere e ricettive. La possibilità di diventare l’unico titolare del diritto di utilizzo turnario da parte di un singolo Tour Operator lascia aperta la possibilità di eliminare la struttura turnaria ed investire nelle strutture per ammodernamenti, frazionamenti e successive rivendite in piena proprietà (non turnaria, quindi a mercato immobiliare).
Cos’è la rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare
La rinuncia abdicativa è il negozio giuridico patrimoniale con il quale il titolare «abbandona» volontariamente la proprietà (e la perde per solo, immediato effetto di tale atto, indipendentemente dalla circostanza che altri la acquisti o che essa si estingua), esercitando così la piena “signoria” sul bene (di qui la differenza rispetto al «rifiuto» – di acquisire un diritto soggettivo o una posizione giuridica di vantaggio dei quali non si è ancora titolari: cfr. artt. 519 e 1411 cod. civ. –). Tale negozio è espressamente contemplato dall’art. 649 cod. civ. (in tema di legato); dall’art. 882 cod. civ. (in tema di riparazione del muro comune); dall’art. 963 (in tema di perimento del fondo enfiteutico); dall’art. 1070 (in tema di abbandono del fondo servente – trattasi, però, più propriamente, di una rinunzia traslativa –); dall’art. 1104 cod. civ. cit. (in tema di comunione) e dagli artt. 1350, n. 5, e 2643, n. 5, cod. civ. (a tenore dei quali l’atto di rinuncia a diritti reali immobiliari richiede la forma scritta ed è soggetto a trascrizione).
In tema di rinuncia abdicativa alla proprietà si è recentemente pronunciato il Tribunale di Roma (sentenza n. 7594/2025), provvedimento che vale la pena di commentare in quanto, pur avendo ad oggetto la cessazione di un procedimento che ha interessato la rinuncia alla proprietà in ambito di multiproprietà reale, ha effettuato un excursus giuridico generale sul tema, sintetizzando lo stato attuale in materia di Giurisprudenza e Dottrina.
L’istituto della rinuncia abdicativa, così come sopra definito all’interno della medesima sentenza, differisce dalla c.d. “rinuncia traslativa”, ovvero della rinuncia a favore di terzi – eventualmente, anche del comproprietario – che se ne arricchisca tout court o che scambi, con il “rinunciante”, una controprestazione. La rinuncia abdicativa è infatti da considerare un negozio giuridico unilaterale formale, che richiede, perciò, nel caso in cui si riferisca a diritti reali immobiliari, almeno la forma scritta – mentre non può fondarsi su meri comportamenti concludenti. Essa, in particolare, incide soltanto indirettamente nella sfera giuridica altrui, poiché, produce, direttamente, la dismissione del diritto di comunione indivisa sulla cosa nella sua interezza (e non già su una singola porzione materiale della stessa), ma, attraverso (ovvero, in conseguenza di) tale dismissione, provoca anche l’accrescimento del diritto degli altri comproprietari, per il principio di elasticità e forzaespansiva della proprietà, oltre che per la natura stessa della comunione. Nello schema di quest’ultima, infatti, il diritto di ogni comproprietario ha per oggetto l’intero bene, ancorché sia limitato nel contenuto dall’insistenza – sullo stesso bene – del diritto degli altri partecipanti alla comunione.
Venuto meno – in tutto o in parte – tale limite, il comproprietario “superstite” vede ampliarsi, in proporzione, la propria quota, fino al punto di cessare di essere mero comproprietario e diventare proprietario esclusivo del bene: ogni partecipante, cioè, è titolare di un autonomo diritto di godimento e di disposizione della cosa nella sua interezza, come si ricava, sul piano normativo, (anche) dal dettato dell’art. 1102 cod. civ., che, nel determinare il potere di godimento del singolo compartecipe sul bene comune, non fa affatto riferimento proporzionale al valore della quota di cui egli è titolare (come, invece, avviene per l’art. 1101 cod. civ.), ma ne afferma l’assoluta pienezza e la massima espandibilità su tutta la cosa, fino al limite, però, in cui l’uso effettivo da parte dell’uno non si risolva in una concreta compromissione di quello che possono farne gli altri.
Si tratta, pertanto, di un atto negoziale intrinsecamente unilaterale e non recettizio, che non implica alcuna conoscenza o accettazione da parte degli altri comproprietari (i quali ben potrebbero restare anche a lungo ignari della vicenda), poiché il diritto che ne è oggetto non viene (non può essere) trasferito o anche semplicemente offerto ad alcuno di loro in particolare, ma viene semplicemente “abbandonato”.
In particolare, la sentenza in commento sottolinea come
“il solo effetto volontario dell’atto è, dunque, la “derelictio” giuridica, la deprivazione del bene, la sua esclusione dal patrimonio del disponente; solo in una fase logicamente successiva e strutturalmente indipendente si viene a determinare l’effetto acquisitivo voluto dalla legge che prescrive l’espansione delle quote. Non sono le parti a volere un trasferimento e non è il negozio a determinarlo. Il negozio determina il mero abbandono della quota e la legge ne determina l’acquisto (con la rilevantissima conseguenza, perciò, che l’arricchimento degli altri comproprietari sfugge alle logiche delle liberalità e il loro acquisto, effetto della legge e non di un altrui attribuzione liberale, avrà carattere di stabilità e non sarà esposto al fastidioso effetto delle azioni di riduzione – ferma, beninteso, la possibilità di fornire la prova che, al di là del nomen iuris, il negozio dissimulava una liberalità). L’esclusione del carattere recettizio, per altro (comunemente ritenuta nei casi di «rifiuto» di acquisto di un diritto), nel caso della rinuncia “abdicativa” alla comproprietà, non è stata ritenuta incompatibile con la rilevata incidenza degli automatici effetti indiretti nella sfera giuridica degli altri comproprietari (che ne viene sia accresciuta – quanto alla consistenza proporzionale della rispettiva quota di diritto/potere sulla cosa dismessa dal rinunciante e, cioè, dei «vantaggi» della comunione: cfr. art. 1101, secondo comma, cod. civ. – sia, simmetricamente, aggravata – quanto alla corrispondente quota proporzionale di obblighi ovvero dei «pesi» della comunione –) né con il principio generale dell’ordinamento, secondo il quale nessuno deve subire direttamente un mutamento (anche soltanto favorevole) della propria sfera giuridica per effetto della (sola) attività negoziale altrui, senza, cioè, che venga necessariamente in considerazione anche una propria “manifestazione” di volontà positiva o negativa, diretta o, almeno, indiretta o implicita (tant’è che è sempre dato l’opportuno rilievo alla volontà del – potenziale – beneficiario, exempli gratia, del contratto a favore di terzo o di disposizioni testamentarie – a titolo universale o particolare che siano – o di rifiutare espressamente di conseguire quell’attribuzione o semplicemente di astenersi dal compiere atti o rendere dichiarazioni idonei/necessari al conseguimento – laddove l’“acquisto” non sia automatico: cfr. artt. 470 e ss. e 519 cod. civ. – oppure – laddove quest’ultimo, invece, si produca automaticamente: cfr. artt. 649 e 1411 cod. civ. – di inficiarlo, rinunciando a profittarne): nel sistema disegnato dal legislatore per la fattispecie in questione, infatti, ognuno dei comunisti residui può successivamente – all’occorrenza – “liberarsi” dell’indesiderato effetto dell’accollo dei maggiori oneri (che consegue “naturalmente” all’altrui rinunzia alla contitolarità del diritto di proprietà) attraverso l’esercizio di un analogo potere di rinunzia, a propria volta, alla (accresciuta quota di) contitolarità di quel diritto.
Appare quindi chiaro come l’atto di rinuncia abbia come unica conseguenza quella di accrescere inevitabilmente il diritto di proprietà piena degli altri comproprietari, effetto che si produce automaticamente, senza necessità di interpellare gli altri comproprietari e in riferimento sia ai diritti di utilizzo che ai relativi oneri che gravano sui proprietari per la gestione della comunione. Il tutto in maniera perfettamente coerente con la salvaguardia dei diritti patrimoniali degli alti comproprietari che, in caso vogliano impedire l’estensione del proprio diritto di proprietà sulla cosa rinunciata, avranno come unica finale possibilità quella di rinunciare a loro volta alla quota rinunciata dal primo comproprietario. Il tutto, nell’ambito di una multiproprietà reale, con potenziale effetto domino dirompente su tutto il bene oggetto di comunione.
Rinuncia abdicativa nella multiproprietà
Da quanto è stato possibile evincere dal commento alla sentenza del Tribunale di Roma, appare chiaro che l’atto di rinuncia abdicativa è uno strumento che può potenzialmente risolvere il problema dei comproprietari all’interno di una multiproprietà reale, che si trovino nella condizione di non poterne più sopportare gli oneri di gestione o che siano in totale disaccordo su questa con gli altri comproprietari. Ovviamente con le dovute cautele, che ben sono riepilogate nella sentenza in commento.
È infatti chiaro che, seppur possibile la rinuncia abdicativa di una proprietà immobiliare, questa nel caso della multiproprietà avrebbe ad effetto da un lato l’estensione del diritto di proprietà degli altri comproprietari alla quota rinunciata, dall’altro l’acquisizione a titolo originario e non derivativo, di un ulteriore diritto di godimento, assegnato da appositi regolamenti alla frazione di proprietà rinunciata. È proprio la commistione tra questi due diritti (la proprietà e il godimento turnario) a rendere difficile l’applicazione dell’istituto della rinuncia abdicativa in questo ambito. Rimarrebbero aperti alcuni quesiti di difficile soluzione tra cui
- L’estensione del diritto di proprietà (coma abbiamo visto perfettamente legale) a favore dei comproprietari, include anche il loro accrescimento del diritto di godimento turnario, comunque separato e frutto di un diverso accordo contrattuale?
- Il godimento turnario, sempre individuato in una unità temporale ulteriormente indivisibile (decade o settimane), in caso di un numero elevato di comproprietari superstiti, costituirebbe una nuova comunione ai sensi dell’art. 1100 c.c.?
- In caso di risposta affermativa a questo ultimo quesito, la comproprietà del diritto di godimento della singola unità temporale sarebbe ulteriormente rinunciabile da parte dei comproprietari?
Considerazioni conclusive
Evidentemente ognuna di queste domande porta inevitabilmente ad una definitiva incertezza sulla possibilità di creazione di infinite comunioni, come in una sorta di “frattale” in senso giuridico, cioè come un ente geometrico caratterizzato da dimensioni non intere e dalla proprietà di riprodurre l’ente di partenza ad ogni scala, sempre più piccola in caso di infinite possibili comunioni residue creabili a seguito di ogni singola rinuncia.
Tale condizione nei fatti configura evidentemente la multiproprietà reale come una condizione di proprietà ontologicamente incedibile per condizioni giuridiche e di mercato, all’interno di una condizione giuridica generale che allo stato attuale presenta gravi incertezze se non profili potenziali di incostituzionalità che, evidentemente, non possono essere tollerati dall’Ordinamento, a tutela sia dei comproprietari che dei consumatori/utilizzatori, nel caso della multiproprietà contrattuale.
È noto che tutte le questioni analizzate e le conseguenti problematiche interpretative, sono già state poste all’attenzione della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che dovrà pronunciarsi a breve a seguito di una remissione datata marzo 2024 del Tribunale di Venezia (cfr. Tribunale di Venezia, Sez. 1, 23 aprile 2024 n. 4569). Si auspica che il supremo consesso si pronunci a breve e che fornisca – finalmente – un’interpretazione univoca sul tema della rinuncia abdicativa.